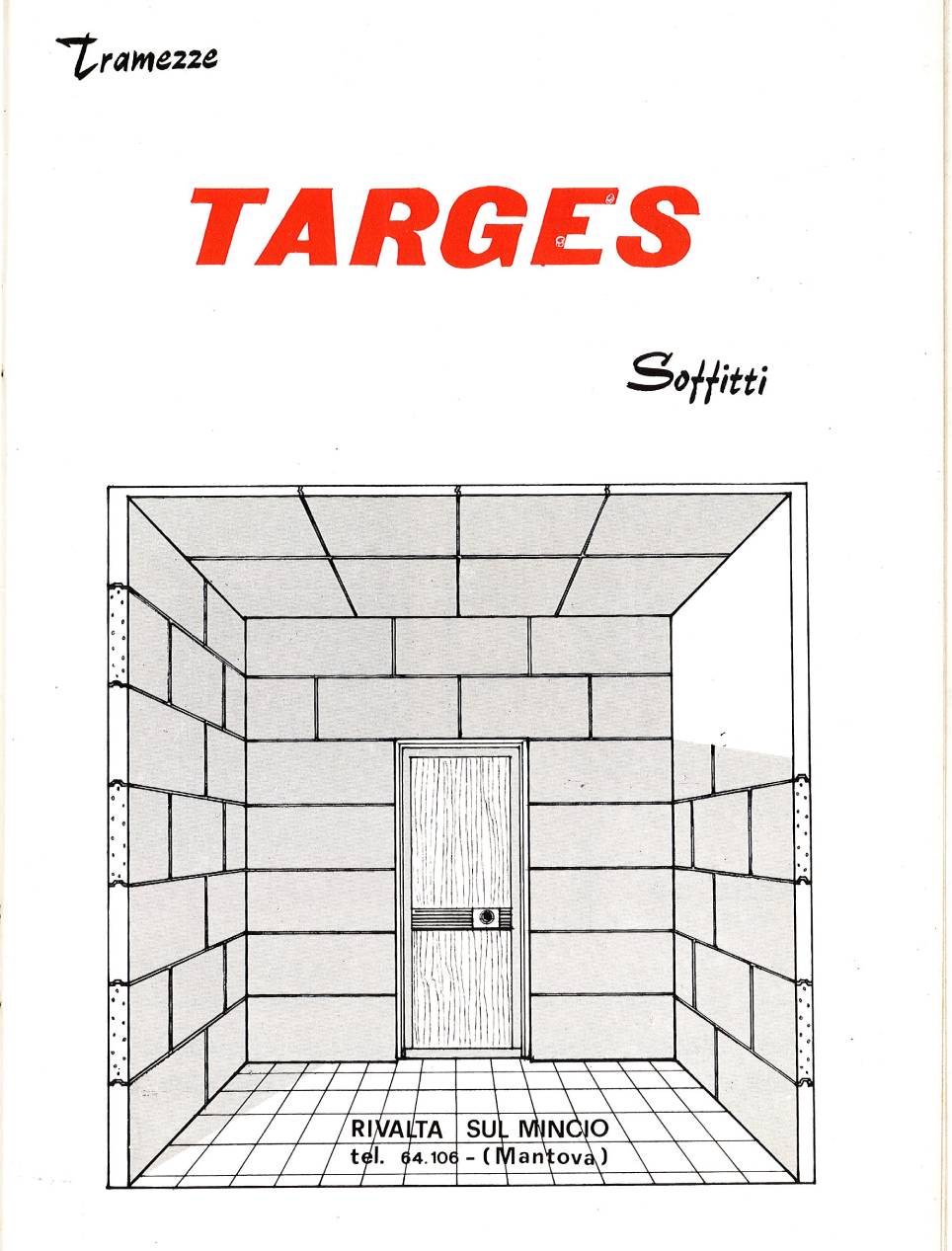La canna palustre

La Canna Palustre
La Canna Palustre
La Valle, (la Val), è un immenso canneto attraversato dal Mincio e da una miriade di canali, (li fösi). La regina incontrastata del canneto è la canna palustre (Phragmites Australis). La pianta presenta il fusto del diametro di un centimetro circa, può raggiungere l’altezza di 5 o 6 metri, ha foglie larghe e infiorescenze fitte e morbide (bósari) con le quali si facevano (li spulvrini) scope speciali che servivano per spolverare. Per fare quelle buone si dovevano utilizzare le canne palustri raccolte nel mese di luglio e comunque non oltre la metà di agosto. A novembre iniziava la raccolta delle canne che venivano tagliate al suolo, esclusivamente a mano, utilizzando una falce (segas), e raccolte in mazzi (masun), unità di misura usata per secoli dai contadini, della circonferenza di 72 cm circa. La misura veniva verificata dalla catena (cadena). Le canne più alte e rigogliose venivano misurate passando, intorno al mazzo, la catena fino all’anello intermedio. Quelle di altezza e qualità inferiore venivano misurate utilizzando la catena da un capo all’altro (mazzi da 92/97 centimetri). Sulle gabarre (batèi) venivano caricati anche 80/100 fasci di canne (canèi), dal peso di 30/35 kg l’uno. Le imbarcazioni in legno venivano spinte controcorrente, a mano, fino a Corte Mincio, qui le canne venivano stoccate, provvisoriamente, utilizzando strutture di appoggio a palizzata in legno (i cavai). Altri operai si occupavano delle successive lavorazioni, le canne venivano ripulite da foglie e rampicanti (squasàdi), selezionate per qualità “al banch” e, infine, tagliate a misura. Raggiungevano, quindi, i vicini laboratori dove le arellaie (arlunsi) provvedevano a trasformarle in graticci (arèli). Con le canne più grosse si realizzavano i sostegni per l’allevamento del baco da seta, i graticci utilizzati come aggrappante per l’intonacatura dei controsoffitti, per essiccare la frutta oppure per ombreggiare le serre in floricoltura. Con quelle più sottili si fabbricavano gli “arlin” utilizzati per ombreggiare i laterizi oppure come avvolgibili da finestra. Le principali destinazioni erano le varie località del nord Italia, in particolare le aziende florovivaistiche della Liguria oltre a varie destinazioni estere tra cui Francia e Svizzera.
Testimonianza di Gino Cristofori
Testimonianza di Gino Cristofori nato a Rivalta sul Mincio il 2 gennaio 1932. Aprile 2022.
Incontriamo Gino insieme al figlio Mattia nella sua abitazione di Rivalta. Novanta anni portati benissimo, appassionato di bicicletta, Gino chiacchera volentieri e ci racconta che dopo aver fatto l’agricoltore, nei primi anni ’50 del secolo scorso, quasi ventenne, inizia a lavorare alle dipendenze della ditta Grassi Luigi, la “Targes” proprio negli anni in cui il figlio del titolare, Socrate, iniziava a studiare e sperimentare la produzione “industriale” di un pannello innovativo. Una lastra in gesso per l’edilizia che si caratterizzava, grazie all’utilizzo come rinforzo interno della canna palustre, per resistenza, coibenza e leggerezza. Fu impiegato fino alla fine degli anni ’60 per la costruzione di opere importanti in diverse zone del territorio nazionale ed europeo, rendendo Rivalta famosa anche per l’invenzione di questo particolare manufatto.
“……….nel laboratorio di Corte Mincio avevamo predisposto un banco di legno che facesse da stampo per il pannello. All’inizio si stendevano 2/3 “dita” di gesso liquido, uno strato di canna palustre tagliata in piccoli pezzi “macarun”, quindi ancora un altro strato di gesso. Si lasciava indurire e si estraeva la lastra. I primi risultati non furono molto soddisfacenti. La lastra non risultava bella liscia e in più crepava. Socrate non si scoraggiò e insieme a Santo Soregotti mi mandò a Firenze, dove acquistavamo il gesso, a “rubare” i segreti del mestiere. In Toscana imparammo che le lastre si staccavano meglio dallo stampo e rimanevano perfettamente lisce se invece del sapone si utilizzava l’olio lubrificante “Fina” in emulsione con acqua. Altre tecniche interessanti da apprendere non ce ne furono. Anche i fiorentini avevano problemi: “l’anima” dei loro pannelli era costituita da cartone a “nido d’ape” e molte lastre crepavano. Quest’ultimo problema noi Rivaltesi lo risolvemmo utilizzando, per la parte centrale del pannello, la canna intera, quella bianca e sottile che raccoglievo insieme a Vittorio Reggiani nella valle nei pressi di Curtatone, insieme ad una spolverata di canapa di scarto tagliuzzata. A questo punto si poté iniziare la produzione in serie delle lastre dello spessore di 6/8 centimetri, alte tre metri e larghe 40 centimetri. Quelle più sottili venivano utilizzate per isolare internamente le stanze accostandole alle pareti esistenti, quelle più spesse venivano utilizzate per la formazioni delle tramezze divisorie.”
Il Debbio
Il Debbio
A fine febbraio o ai primi di marzo, quando la raccolta della canna era già terminata, la Valle veniva bruciata. Era un fuoco che non spaventava la gente di Rivalta perché sapeva che veniva acceso con criterio da alcuni uomini che, con un’esperienza tramandata da generazioni, appiccavano fuoco a sterpaglie ed erbe morte o infestanti per favorire la ricrescita delle canne e un futuro abbondante raccolto. Con perizia governavano fiamme altissime che diffondevano i resti carbonizzati delle canne per tutto il territorio circostante. Questa pratica spettacolare, insieme alla regolazione sapiente del livello delle acque, garantiva una palude sana e fertile, inoltre, contribuiva ad evitare l’autobonifica della Valle e l’intasamento dei canali, lasciando libero spazio al transito dei battelli. La pratica del debbio è ormai in disuso da qualche anno, ed è vietata per non creare ulteriore inquinamento atmosferico.
L'abbigliamento del raccoglitore della Canna Palustre
L’abbigliamento del raccoglitore della Canna Palustre
Li “sgàlmari” e i “sgalmarun” erano calzature in cuoio, indispensabili per camminare sull’inconsistente terreno della Valle. Grossi scarponi le prime, stivali con gambale le seconde, erano dotate di un’ampia suola di legno molto spessa, rinforzata con una lamina metallica. Queste calzature presentavano un duplice vantaggio: riducevano lo sprofondamento nel fango e proteggevano gli arti inferiori dalle stoppie taglienti lasciate sul terreno dopo il taglio della canna, che potevano produrre ferite molto pericolose. Questo pericolo era costante, considerato che la canna veniva tagliata dal basso verso l’alto, lasciando a terra un troncone con la punta molto tagliente. Gli “stafanèi” , ritagli di copertoni d’auto legati dietro le gambe, servivano a proteggere le ginocchia. I “mangòt” , invece, erano delle mezze giacche con una manica sola che riparavano la parte del petto e il braccio in cui si appoggiavano i fasci delle canne da tagliare.
Testimonianza tratta dalla pubblicazione "Terra e Acqua"
Testimonianza tratta dalla pubblicazione “Terra e Acqua” di Giancorrado Barozzi del luglio 1997
Il lavoro in valle nascondeva pericoli e paure. Non solo malattie (leptospirosi e malaria) o ferite profonde ma anche insidie legate a situazioni specifiche che molto spesso venivano affrontate con battute scherzose per cercare di sdrammatizzare. Certe volte, per esempio, capitava di tagliare le canne sopra un “cüròt”, isolotto galleggiante venuto giù con le piene (cresent). Ti sentivi sprofondare, ed era difficile reggersi in piedi anche perché gli abiti pesanti non aiutavano a mantenere l’equilibrio e per questo non era difficile cadere in una buca. In queste occasioni quando i compagni di lavoro ti vedevano sprofondare nell’acqua e nel fango ti domandavano per scherzo: “cusa et ciapà?”, che cosa hai preso? E il malcapitato, per stare al gioco doveva rispondere a tono: “na tenca”, una tinca.